(generalità ,
caratteristiche , distribuzione )
CENNI STORICI
Il primo
pianetino fu scoperto da un italiano, Padre Giuseppe
Piazzi l' 1 gennaio dell' anno 1801.
Piazzi
nacque a Ponte , borgo della Valtellina il 16 luglio
1746.
Nel 1764
entrò nell' ordine dei Teatini per studiare Astronomia,
Matematica e filosofia a Torino e più tardi a Roma dove,
grazie agli insegnamenti dei Padri Le Seur e Jacquier, si
perfezionò in matematica.
Nel 1769 fu
maestro di filosofia a Genova e successivamente (1770)
maestro di matematica all' università di Malta per
passare a Ravenna come lettore di filosofia e poi a
Cremona e a Roma.
L'
università di Palermo gli assegnò nel 1780 la cattedra
di Calcolo Sublime e l' incarico di seguire l' opera di
costruzione della Specola Astronomica, di cui diverrà
Direttore per volere del Re Ferdinando I di Borbone.
E' presso l'
Osservatorio che intraprese il lungo e faticoso lavoro di
compilazione del "Catalogo
Stellare" un' opera contenente le
posizioni accurate di oltre 7600 stelle (nata con l'
intento di perfezionare i cataloghi dell' epoca non privi
di numerosi errori) che concluderà nel 1813 e
pubblicherà l' anno successivo con il titolo "Praecipuarum
stellarum inerrantium positiones mediae ineunte saeculo
decimonono ex observationibus habitis in Specula
Panormitana ab anno 1792 ad annum 1813".
Proprio nel
corso del lavoro di osservazione per la realizzazione del
"Catalogo" egli, la
notte del 1 gennaio 1801, scoprì quella che credette
essere una nuova stella.
Nelle
successive osservazioni si rese però conto , a causa del
moto del corpo tra le altre stelle, che dovesse trattarsi
di un oggetto appartenente al Sistema Solare, forse una
cometa o un nuovo pianeta.
Ben presto
la prima ipotesi venne scartata a causa della mancanza di
una chioma o di una coda visibili e del moto costante del
corpo celeste , ben diverso da quello tipico di una
cometa.
Certamente
in Piazzi si fece strada l' idea che si trattasse di un
nuovo pianeta (1) e continuò ad
osservarlo e a trarne posizioni astrometriche fino a
metà febbraio dello stesso anno quando, l' approssimarsi
al Sole impedì la continuazione delle osservazioni.
Così
comunicò la sua scoperta a Barnaba Oriani direttore
della specola di Brera in una lettera datata: Palermo 24
gennaio 1801.
"Amico
carissimo sebbene le attuali
circostanze politiche (2)
abbiano interrotta ogni nostra corrispondenza, azzardo [non
di] meno di scrivervi,impaziente di darvi una
nuova che non vi sarà discara. Il dì primo di gennaio
osservai nella spalla del Toro una stella di 8^ g. la
quale nella sera seguente, cioè lì 2 si avanzò di 3'
30" circa verso il nord e di 4' circa verso la
sezione di Ariete. Verificai le mie osservazioni lì 3 e
4 e notai lo stesso movimento prossimamente. I giorni
5.6.7.8.9 il cielo fu coperto .
Rividi la
stella lì 10 e 11 e poi lì 13.14.17.18.19.21.22.23.
La sua [AR]
nella prima osservazione era 51°17' e la declinazione
16°4'.15: dai 10 agli 11 da retrograda divenne diretta,
e nell' osservazione di 23 [AR]
51°46' , declinazione 17°8'. Io ho annunziato questa
stella come cometa; ma il non essere essa accompagnata da
alcuna nebulosità ,e più il suo movimento così lento e
piuttosto uniforme mi ha fatto più volte cadere nell'
animo che forse possa essere qualche cosa meglio di una
cometa. Questa congettura, però mi guardai bene di
avanzarla al pubblico. Quando avrò un maggior numero di
osservazioni tenterò di calcolarne gli elementi.
Intanto
amerei moltissimo, che voi procuraste di osservarla, mi
diceste ciò che ne pensate, e se da altri sia stata
veduta...." conclude con i saluti di
rito. (lettera originale conservata negli archivi storici
dell' Osservatorio di Brera - MI)
Il problema
che si poneva a questo punto era ,come dice lo stesso
Piazzi nella sua lettera,quello di calcolare gli elementi
orbitali per riuscire a ritrovare il corpo celeste e
riosservarlo dopo un certo periodo di tempo.
Purtroppo
,all' epoca, si era in grado di eseguire questo tipo di
calcolo solo se la serie di osservazioni era ben
distribuita su un grande arco dell' orbita ma, per l'
astro scoperto dal Piazzi, si avevano a disposizione solo
osservazioni su un breve tratto di questa.
Si deve a
Gauss ,allora ventiquattrenne, il merito di aver messo a
punto un metodo per il calcolo delle orbite basato su
sole tre osservazioni ravvicinate e perfezionabile
(mediante il metodo dei minimi quadrati) usando tutte le
osservazioni disponibili (3).
Fu possibile
utilizzare questo metodo,di tipo geometrico e di facile
applicazione, al nuovo corpo celeste e ciò permise di
rintracciare il pianetino non appena Gauss, nel dicembre
del 1801 potè prevederne la posizione attraverso il
calcolo.
Piazzi
chiamò il pianetino da lui scoperto Cerere Ferdinandea
in onore della antica Dea italica delle messi (4)
e del re Ferdinando I di Borbone.
Grande fu l'
entusiasmo per questo ritrovamento anche perchè il 28
marzo 1802 seguì la scoperta di un nuovo corpo ,Pallade,
da parte di Olbers , un Astronomo dilettante di Brema che
intuì che probabilmente gli oggetti appartenenti a
questa fascia dovessero essere numerosi ed intraprese una
campagna di ricerca con la collaborazione di
J.H.Schröter che possedeva un grande osservatorio
privato.
Ora, in
onore di Piazzi, Gauss ed Olbers , i pianetini numerati
1000 , 1001 , 1002 portano rispettivamente i nomi di Piazzia
, Gaussia , Olbersia.
Il terzo
pianetino ,Giunone, fu scoperto l' 1 settembre 1804 da
Harding, uno degli astronomi dell'Osservatorio di Brema e
il quarto , Vesta , fu nuovamente scoperto da Olbers il
29 marzo 1807.
Grande fu la
genialità di Olbers, non solo per le scoperte
effettuate, ma anche per essersi spinto ad ipotizzare che
dovevano esistere molti di questi corpi concentrati in
una zona ben definita ed addirittura azzardare l' idea
che fossero il resto di un pianeta più grande esploso in
epoche remote (quest' ultima ipotesi oggi è stata
confutata dalle teorie e dalle osservazioni che le
sostengono ma ciò non sminuisce sicuramente l' opera e
lo spirito scientifico di questo grande astronomo).
Dopo la
scoperta dei primi 4 pianeti minori trascorse un periodo
relativamente lungo prima che se ne identificassero altri
, Bisogna infatti attendere l' 8 dicembre 1845, data in
cui Encke ,un' altro astronomo dilettante, scoprì
Astraea; l'evento ebbe tale rilievo che il Re di Prussia
assegnò allo scopritore un vitalizio annuo di 1200
marchi in oro. Da allora le scoperte si susseguirono ad
opera di astronomi ma spessissimo di dilettanti, dapprima
visualmente e,poi fotograficamente fino ai nostri giorni.
[ NOTA
1 ]
Che dovesse
esserci un pianeta tra le orbite di Marte e Giove (qui si
trova infatti Cerere) era stato ipotizzato dall'astronomo
Titius ( nome latinizzato di J.G.Tietz prussiano, nel
1766 ) in una legge divulgata da Boode (tedesco direttore
dell' Osservatorio di Berlino, nel 1778) che prese il
nome di legge di Titius-Boode . Essa permette di fissare
in modo approssimato le distanze dei pianeti dal Sole. Il
procedimento è il seguente:
- scrivere
la progressione geometrica:
0 3 6 12 24
48 96 192 384 768
- aggiungere
il n° 4 ad ogni termine in modo che risultino:
4 7 10 16 28
52 100 196 388 772
- dividere
questi nuovi termini per 10:
0.4 0.7 1
1.6 2.8 5.2 10 19.6 38.8 77.2
si ottengono
dei valori che sono in buon accordo con le distanze medie
dei pianeti dal Sole se si eccettua la quinta che
potrebbe rappresentare appunto la distanza dei pianetini.
[ NOTA
2]
Siamo un un'
epoca di grandi sconvolgimenti politico-militari ma anche
di grande fervore scientifico favorito dal mecenatismo
napoleonico: verso la fine del 1797 Francia e Austria
firmano la Pace di Campoformio a seguito della quale
Napoleone cede le regioni del Veneto all' Austria e
costituisce la Repubblica Cisalpina formata dai territori
delle Repubbliche Transpadana e Cispadana , dalla
Valtellina e dai territori veneti che non erano stati
ceduti all' Austria.
La campagna
d'Egitto di Napoleone del 1798 provoca la formazione
della cosiddetta 2^ coalizione contro la Francia
sostenuta dall' Inghilterra cui aderiscono l'Austria, la
Russia la Turchia e il Re di Napoli. Il governo
napoletano nella euforia dovuta ai successi britannici ad
Abukir, invia un esercito contro la Repubblica Romana. In
risposta i francesi invadono il Napoletano e vi
instaurano la Repubblica Partenopea , destinata a durare
ben poco.
La notizia
della seconda coalizione raggiunge Napoleone in Egitto e
i fatti che seguono portano ad un colpo di stato in
Francia a seguito del quale egli diventa Primo Console (9
nov. 1799).
Altre
vittorie vengono a consolidare il potere della Francia,
nel 1800 a Marengo Napoleone, grazie ad un imprevisto
interervento del generale Desaix, sconfigg gli austriaci
ed i loro alleati, e Moreau li batte in modo decisivo a
Wohenlinden. La pace di Lunéville (1801) riporta la
Francia di nuovo oltre i confini nazionali: il Belgio, la
Svizzera e il Piemonte rientrano nell'orbita francese.
Tornano a risorgere la repulbblica batava (Olanda), la
repubblica elvetica e si forma la repubblica italiana sui
resti della Ligure e della CisaIpina. La Toscana viene
trasformata in regno d'Etruria e affidata al duca di
Parma, mentre il ducato di Parma viene annesso alla
Francia. La Germania viene divisa tra la Prussia ed
alcuni Stati amici della Francia. [ tratto da G.De Rosa -
Storia Moderna ]
[ NOTA
3 ]
Così Ian
Steward parla di questo metodo in una biografia di Gauss
sul n° 111 del novembre 1977 della rivista Le Scienze:
. . . Dopo
solo tre osservazioni Gauss mise a punto una tecnica per
calcolare le componenti orbitali con una precisione tale
che tra la fine del 1801 e I'inizio del 1802 parecchi
astronomi furono in grado di ritrovare Cerere senza
difficoltà. Tra I'altro egli mostrò che le variazioni
relative alle informazioni ricavate sperimentalmente
potevano essere rappresentate da una curva a campana
(meglio conoseiuta oggi come distribuzione gaussiana).
Egli mise a punto anche il metodo dei minimi quadrati,
mediante il quale il valore più attendibile viene
ricavato con un particolare calcolo che minimizza le
somme di differenze al quadrato. I suoi metodi, descritti
in un suo articolo del 1809 dal titolo "Teoria del
moto dei corpi celesti che ruotano attorno al Sole su
sezioni coniche" sono ancora impiegati oggi. Sono
necessarie soltanto poche modifiche per renderli adatti
ai moderni elaboratori elettronici.
Gauss ebbe
lo stesso successo nel determinare l' orbita
dell'astcroide Pallade , per il quale perfezionò i suoi
calcoli per tener conto delle perturbazioni prodotte
dagli altri pianeti del sistema solare ...
[ NOTA
4 ]
Cerere (Mit.
Rom.). Dea della vegetazione e delle biade; è un'
antichissima divinità italica, associata nel culto alla
dea Tellure con la quale veniva onorata nelle feste dette
Paganalia e in quelle che si celebravano in gennaio
(Ferie Sementive). Nel periodo repubblicano con l'
introduzione in Roma del culto delle divinità greche, C.
venne confusa con la Demetra greca, tanto da attribuire
ad essa tutte le leggende riguardanti questa dea.
C. fu cara
particolarmente ai plebei. i cui rappresentanti avevano
in custodia il suo tempio, che venne costruito vicino al
Circo Massimo dal dittatore Aulo Postumio dopo una
terribile pestilenza.
In suo onore
si celebravano le feste dette Cerialia; le si
sacrificavano le scrofe. a lei sacre, e le si offrivano
le primizie dei campi.
A Roma fu
venerata insieme con Libero e Libera . Probabilmente
viene associata alla Sicilia, granaio d' Italia, in
quanto Dea delle messi.
[Da: Corrado
D'Alesio -Dei e Miti - Edizioni Labor]
MODALITA'
DI RICERCA PASSATA E ATTUALE
Quattro sono
fondamentalmente i metodi di osservazione dei pianetini
utilizzati dal passato ad oggi:
- visuali
-
fotografici
-
fotoelettronici
-
elettronici
esaminiamoli
singolarmente escludendo quei metodi che fanno uso di
apparecchiature particolari quali gli strumenti dei
passaggi che non sono utilizzabili,in genere, da
astronomi amatori.
METODI
VISUALI
sono stati
utilizzati dal 1800 fino all' avvento della fotografia
benchè, anche oggi, esistano astrofili che li utilizzano
ed associazioni che pubblicano i dati di posizione
ottenuti visualmente. distinguiamo tra:
- metodiche
per il calcolo astrometrico della posizione
- metodi per
la determinazione della magnitudine.
1)sistema
di lettura dai cerchi graduati: consiste nel
centrare l' oggetto mediante un oculare munito di
crocicchio e leggere direttamente la sua posizione sui
cerchi graduati del telescopio; è il sistema più antico
e permette, se lo strumento è perfettamente a punto, di
ottenere precisioni dell' ordine del decimo di grado,
nella migiore delle ipotesi(oggi inaccettabili).
2)sistema
del reticolo graduato: mediante un reticolo
graduato di precisione si stima la distanza del pianetino
da alcune stelle di confronto poste nel campo dell'
oculare,sia in ascensione retta che in declinazione e si
risale poi alle coordinate cercate mediante una semplice
proporzione o attraverso uno dei metodi classici
(Dipendenze, costanti di lastra).
3)Sistema
della misura temporale per l' Ascensione Retta:
vale solo per questa, e consiste nel cronometrare il
tempo che intercorre tra il passaggio del pianetino e
quello di una stella di confronto, sul filo di un
reticolo posto nell' oculare di un telescopio con il moto
di ascensione retta spento. Sommando o sottraendo il
tempo cronometrato alla A.R. della stella si ricava
direttamente la coordinata del pianetino.
4)sistema
del micrometro filare: fa uso del citato
strumento utilizzato in passato per la misura delle
stelle doppie. Consiste nel misurare la distanza tra il
pianetino ed alcune stelle di riferimento relativamente a
due assi perpendicolari.
METODI
FOTOGRAFICI
Consistono
nel ricavare misure astrometriche direttamente dalle
lastre fotografiche ottenute con sistemi atti a rilevare
la presenza di pianetini:
- pose
lunghe affinchè si rilevi la traccia dell' oggetto
dovuta al
suo moto;
- pose
intervallate di un tempo necessario affinchè l' oggetto
cambi posizione dall' una all' altra posa ...
Generalmente
l' astrofilo utilizza il secondo metodo, eseguendo due
pose ad una distanza temporale variabile dai 15 min all'
ora (in dipendenza della focale del telescopio) in modo
che eventuali pianetini si presentino leggermente
spostati dall' una all' altra posa.
Questi
metodi richiedono di dotarsi di due strumenti:
-Il BLINK
che è un particolare microscopio in grado di
visualizzare alternativamente porzioni di due lastre in
modo che un eventuale pianetino possa essere rilevato dal
suo tipico saltellare dovuto al fatto che, contrariamente
alle stelle, occupa sulle due pose una diversa posizione.
-Il MISURATORE
che permette di ottenere la posizione dell' oggetto e di
alcune stelle di riferimento e che è costituito da un
microscopio abbinato ad un sistema micrometrico di
misura.
METODI
FOTOELETTRONICI
Si fondano
sulla digitalizzazione di immagini fotografiche mediante
scanner ad alta definizione e sono supportati da
programmi altamente sofisticati di riconoscimento.
Lo sviluppo
attuale della tecnologia elettronica e il costo
relativamente basso degli scanner potrebbe permettere l'
accesso a questa metodica anche agli astrofili (5).
METODI
ELETTRONICI
Fanno uso di
telecamere CCD applicate direttamente al fuoco del
telescopio. In questo testo l' argomento viene
diffusamente trattato nei capitoli che seguono.
[ NOTA 5
]
Oggi la
digitalizzazione delle immagini è veramente accessibile,
non solo per il costo contenuto degli scanner, ma anche
per la possibilità di far digitalizzare le immagini
direttamente dal proprio laboratorio fotografico tramite
il metodo PHOTO-CD . Se ne otterranno delle immagini su
disco ottico CD-ROM direttamente leggibili tramite un
lettore collegato al computer. Esistono poi programmi di
grafica commerciali (Corel , Perceive ... ecc.) che
possono permettere di elaborare le immagini ed anche di
misurare con discreta precisione la posizione di un
punto.
Vi sono
anche programmi specifici (come "PENELOPE" o
"TEAM"descritto più avanti in questo libro)
che permettono di ottenere misure astrometriche di alta
precisione da porzioni di immagini digitalizzate.
DISTRIBUZIONE
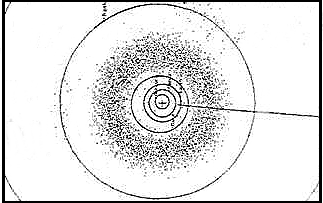
Nella
figura possiamo avere un'idea della distribuzione dei
pianetininel Sistema Solare.
La
maggior parte ruota su orbite comprese tra quella di
Marte e quella di Giove (fascia principale), ma esistono
anche addensamenti su orbite poste a diverse distanze dal
Sole che si alternano con zone relativamente vuote (dette
lacune) nel rispetto di precise regole di risonanza
dovute all' influenza gravitazionale dei pianeti
maggiori.
Ecco
i principali:
| GRUPPO
|
ORBITA
|
NOTE
|
| Aten |
Interna alla Terra
|
oggetti di piccolo
diametro |
| Apollo-Amor
|
Tra Terra e Marte
|
possono intersecare l'
orbita terrestre |
| Hungaria |
Prossima a Marte
|
orbite quasi circolari
|
| Hilda |
Circa 3.5 U.A.
|
periodo 2/3 Giove
|
| Troiani |
Coincidente con Giove
|
periodo 1/1 Giove
|
| Transgioviani
|
esterna a quella di
Giove |
Hidalgo
la cui orbita ha il perielio nella fascia
principale e l' afelio prossimo all' orbita di
Saturno. Chirone
con l' orbita fra Saturno e Urano
|
| Fascia di Kuiper
|
Oggetti la cui orbita
si pone generalmente oltre quella di Nettuno.
|
|
NB:
Generalmente ogni gruppo prende il nome dal primo
pianetino scoperto o da quello più importante.
L'
istogramma mostra la distribuzione di pianetini alle
diverse distanze dal Sole.
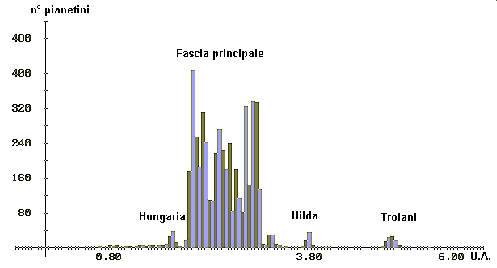
fig.2
LE
FAMIGLIE
Abbiamo
visto che, esaminati dal punto di vista della distanza
dal Sole (semiasse maggiore), i pianetini tendono a
distribuirsi in gruppi ben definiti ed intervallati da
Lacune.
E' possibile
prendere in considerazione altri parametri orbitali alla
ricerca di altri possibili addensamenti.
Nel 1918 un
giapponese, Hirayama provò a rappresentare la
distribuziione dei pianetini in uno spazio cartesiano
tridimensionale le cui coordinate erano , oltre al
semiasse, l'eccentricità e l'inclinazione.
Questa
analisi mise in evidenza numerosi addensamenti che
vennero definiti "famiglie dinamiche", note
oggi con il nome di Famiglie di Hirayama.
E' bene
precisare che questi addensamenti esistono solo nella
rappresentazione cartesiana sopra nominata e non esiste
relazione con la vicinanza nello spazio reale.
Lo studio di
questi addensamenti è tuttora in corso, anche se
l'ipotesi accettata dai piu, è che ogni famiglia sia
originata dalla frammentazione di un oggetto progenitore
dovuta a fenomenologie di tipo collisionale.
DIMENSIONI
E CARATTERISTICHE
La
dimensione dei pianetini varia da corpi con diametro
intorno al migliaio di Km (Cerere) a corpi piccolissimi
inferiori al centinaio di metri a cavallo del limite di
demarcazione con le meteoriti (che peraltro assumono
questo nome nel momento in cui "cadono" sul
nostro pianeta).
Per
l'osservatore terrestre appaiono comunque con aspetto
puntiforme ed è impossibile distingguerli dalle stelle,
anche quando transitano vicino alla terra, solo con le
sonde spaziali si è riusciti ad averne un'immagine. Per
i diametri maggiori la forma si avvicina molto alla sfera
, mentre i piu piccoli si presentano come solidi
sferoidali, ma alquanto deformati , la superficie è
normalmente butterata da crateri e ci ricorda molto la
superficie lunare.
Anche la
loro natura chimica ci ricorda molto al Luna, ma
soprattutto le meteoriti con le quali dovrebbero dividere
la stessa origine, sono quindi costituiti da rocce della
medesima specie di quelle analizzatre sulle meteoriti
cadute sulla Terra.
Il loro
albedo , cioè la capacitàdi riflettere la luce, è
molto basso e può variare dal 5 al 15% a seconda della
loro natura cabonacea o basaltica,
Lo spettro
della loro emissione luminosa è continuo dal blu fino
all'infrarosso vicino, però con un incremento quasi
costante che porta il massimo intorno alle lunghezze
d'onda di un micrometro. L'emissione a questa lunghezza
d'onda normalmente è un 30% maggiore rispetto al blu.
L aloro
magnitudine apparente , cioè quella che possiamo
osservare dalla Terra, varia da un massimo intorno ad 8
per i piu luminosi fino ad un limite estremo concesso
dalle capacità dello strumento e dal cielo, però varia
moltissimo in funzione delle condizioni geometriche di
osservazione o meglio dire della distanza dell'oggetto
dalla Terra e dal Sole. Le migliori condizioni si avranno
naturalmente quando le distanze saranno minime e quindi
intorno alla fase di opposizione.
L'origine
dei pianetini va ricercata nella formazione del Sistema
solare primordiale, di cui questi corpi
rappresenterebbero la traccia fossile piu evidente,
potendoli paragonare ai planetesimi che hanno dato
origine alla formazione dei pianeti maggiori. Del resto
gli studi piu recenti testimoniano un'origine da
frammentazione per molti asteroidi dovuta al fatto che ,
nella zona della fascia principale, le perturbazioni
gravitazionali dovute ai pianeti maggiori , favorirebbero
incontri distruttivi piuttosto che costruttivi come
quelli che si ipotizzano per i pianeti di tipo terrestre.
|


